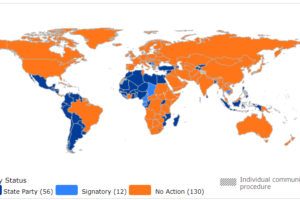Il linguaggio è uno dei più potenti mezzi che abbiamo a nostra disposizione, una facoltà in grado di cambiare il mondo, le nostre vite e quelle di chi ci circonda. Le parole non sono mai casuali, neppure quando ne siamo inconsapevoli, perché rappresentano la manifestazione di ciò che pensiamo e del modo in cui vediamo o del modo in cui vogliamo descrivere l’oggetto del nostro discorso. Le parole possono curare ma anche ferire, possono incentivare ma anche bloccare, possono creare ponti ed erigere muri e possono umanizzare ma anche disumanizzare. Le parole, inoltre, tendono a plasmare le situazioni a cui si riferiscono, fornendo prospettive diverse e creando un immaginario che fa leva su specifiche emozioni.
Nel definire le questioni relative alla migrazione, le parole utilizzate costituiscono un importantissimo strumento per creare una percezione del tema nell’intera società. Un linguaggio di frequente politicizzato e non umanizzato, che viene utilizzato per spostare preferenze elettorali e potenziali voti.
Quando un Primo Ministro del Regno Unito definiva “sciame di migranti” le persone che tentavano disperatamente di accedere al Regno Unito dal porto francese di Calais, quando un Presidente degli Stati Uniti d’America sottolineava come le persone migranti “infestano il nostro Paese”, quando un Ministro degli Interni italiano definisce “carico residuale” delle persone che hanno subito torture e attraversato il Mediterraneo ci rendiamo conto di quanto le parole possano plasmare la realtà.
Nell’immaginario collettivo si diffonde una percezione disumanizzata e non empatica nei confronti di esseri umani che come tutti hanno alle spalle una storia e una famiglia, emozioni e paure, oltre a un vissuto traumatico. Le persone migranti, invece, vengono spesso rappresentate come un gruppo omogeneo senza storie personali, senza origini e caratteristiche uniche, senza umanità. Descrizioni alle quali la società si è così assuefatta da non riuscire più a provare una sensazione di vicinanza emotiva, come se a rischiare la vita su quei barconi nel mare o nei campi di tortura libici non ci fosse una persona come quelle che incontriamo tutti i giorni, come un nostro caro o un familiare. Così la persona diventa il clandestino, l’irregolare, il carico residuale.
Il linguaggio utilizzato crea così pregiudizi, diffidenza, paure, chiusure, quando non si spinge a richiamare una pericolosa logica di invasione e quando non richiama una pericolosa deriva di odio razziale e di richiamo ai drammatici tempi della tratta. Rischi che si corrono nel moltiplicarsi di articoli online e sulla carta stampata, di fake news e di commenti sui social, quando, ancor peggio, non entrano nelle stanze istituzionali.
Eppure, quando coloro i quali si spostano da un Paese all’altro non provengono dai Paesi più poveri della Terra smettono di chiamarsi migranti e si chiamano expats, smettono di fare paura e repulsione ma diventano risorsa, o almeno non vengono considerati alla stregua di invasori da respingere o alla stregua di merci che vengono mandate da un porto all’altro in balia delle onde.
Le parole sono anche alla base del processo di integrazione e del modo in cui nelle nostre città e nella nostra società, forniamo strumenti e garantiamo i diritti delle persone che vengono accolte. Parole che possono portare a esempi di arricchimento culturale e crescita comune e parole che invece possono generare ghettizzazione e isolamento.
Per questo motivo, in questo momento così delicato, tra conflitti e nostalgiche velleità di chiusura, possiamo sperare di iniziare un percorso di cambiamento a partire dai termini e dalle definizioni che utilizziamo, facendo sì che il linguaggio inclusivo posso sostituire quelle parole che creano divisioni, che distruggono e non costruiscono, che distanziano e non uniscono. Un primo piccolo tassello che possa scongiurare che un certo tipo di linguaggio diventi l’anticamera di un mondo che non vogliamo.